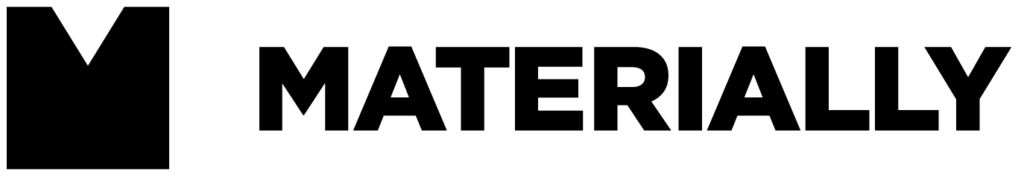The Scale of Commitment – Incipit
Il 4 marzo scorso l’ADI Design Museum ha ospitato il primo evento del calendario di incontri
e mostre curati da Materially per la Milano Design Week 2025. La scelta di anticipare una
conversazione approfondita sul tema che è al centro delle iniziative di aprile – la misurazione
dell’impatto ambientale e della performance dei materiali – è stata premiata da una
partecipazione di speaker di livello che hanno presentato esperienze e punti di vista molto
diversi lungo la catena del valore del progetto di design. Presentiamo qui i principali take
away della mattinata, moderata da Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile.
Omar Degoli, Head of Environment and Circular Economy di FederlegnoArredo, ha
presentato la sfida di trasferire l’esempio ben riuscito della normativa Ecodesign dei prodotti
elettronici nel nuovo regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), in
corso di definizione per cinque settori, tra cui tessile, arredo e acciai.
Varie le opzioni a disposizione della Commissione Europea. Tra queste, i protocolli
ambientali o criteri ambientali minimi, cioè set di criteri non scientifici ma capaci di toccare
aspetti significativi per una categoria di prodotti come i mobili; e la misurazione delle
caratteristiche effettive del prodotto, per esempio l’impronta di carbonio da riportarsi
nell’EPD (Environmental Product Declaration). Si tratta di un approccio mutuato
dall’esperienza dei prodotti elettronici ed è un tipo di valutazione non favorevole a produzioni
basate sulla qualità, come quella italiana, meno riconoscibili da un punti di vista scientifico.
FederlegnoArredo spinge più verso un sistema basato su standard tecnici di prodotto
sviluppati nel tempo, un corpus già esistente e che si potrebbe rendere più cogente. Si tratta
di requisiti che affrontano l’allungamento della vita del prodotto o la riduzione dei rifiuti, un
patrimonio di standard tecnici da cui si potrebbe attingere per definire criteri capaci di
promuovere qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti, senza dare ulteriori oneri
all’industria e andando a toccare il tema dell’obsolescenza, cioè l’aspetto forse più innovativo
dell’ESPR.
Sara Corrado, Group LCA Lead del Center of Excellence for innovation and Technology di
Broadview, ha raccontato come l’LCA (Life Cycle Assessment) è diventata nel tempo uno
strumento imprescindibile per la valutazione dei prodotti di un gruppo globale che vanta nel
suo portafoglio brand di laminati e rivestimenti tra i più importanti al mondo, quali Formica e
Fenix. L’attenzione del gruppo alla sostenibilità ha una lunga storia. Nel 2010 si sono fatte le
prime LCA con consulenti esterni, dal 2017 è stato fondato il dipartimento di sostenibilità che
ora vanta tredici persone.
Se inizialmente l’LCA veniva utilizzata per scopi interni quali la quantificazione degli impatti
delle aziende a monte del ciclo produttivo, più di recente Broadview l’ha utilizzata anche
nella comunicazione a livello di prodotto in forma di EPD, espandendo l’analisi oltre la
misurazione dell’impronta di carbonio, focus principale dei primi assessment interni.
Il Gruppo si è dotato anche di un EPD Process Certification, che permette di certificare il
sistema con cui viene fatta l’LCA. I temi della attendibilità e comparabilità dei risultati,
dunque della trasparenza delle fonti e i metodi utilizzati, sono infatti molto rilevanti a causa
della mancanza di criteri certi e univoci relativi ai dati secondari. Al di fuori di quanto viene
prodotto dalle fabbriche controllate, parametri come il consumo energetico provengono
infatti da medie calcolate in modo diverso a seconda dei database di riferimento. Alto è il
rischio che EPD di prodotti simili non siano correttamente comparabili, dunque benvenuta la
creazione di un database a livello europeo attualmente in discussione.
Lamberto Lamberti, Head of Lamberti Group Sustainability, ha sottolineato quanto la
misurazione sia un concetto intrinseco al business Lamberti, società che sviluppa ingredienti
innovativi per vari settori tra cui energia, agricoltura, trattamento delle superfici, ceramica,
cura della persona e polimeri naturali. Questo approccio scientifico alla misurazione guida il
miglioramento verso nuove categorie di utilizzo garantendo progressi misurabili, sostenibili e
integrati.
Nell’ultimo decennio il design ha sviluppato nuove esigenze applicative e performative, come
materiali più leggeri, più resistenti o più sostenibili e al contempo un forte interesse verso la
misurazione delle prestazioni nell’intero ciclo di vita di materiali e prodotti. Anche su questo
stimolo Lamberti ha continuato ad investire nella ricerca e sviluppo e nella misurazione dei
parametri di sostenibilità, sempre più richiesta dai loro clienti.
Serena Gazzo, Sustainability Data Analysis Manager di Lamberti SpA ha spiegato in
dettaglio come questa esigenza di mercato sia stata affrontata dall’Azienda attraverso la
formazione tra il 2020 e il 2021 di un team interno dedicato al Life Cycle Assessment. Già
nella sua composizione – una figura specializzata in certificazioni normative, una in
comunicazione, due R&D chimici – il team riflette le esigenze strategiche di Lamberti, in
particolare, in un’ottica di eco design, l’obiettivo di guidare l’R&D ad ottimizzare processi
ancora in fase di sviluppo in laboratorio per arrivare alla fase industriale con performance
ambientali ottimizzate.
Con il continuo aumento di richieste di LCA – 150 negli ultimi tre anni per 40 clienti europei
ed extraeuropei – Lamberti ha deciso di sviluppare una piattaforma digitale che permetta di
velocizzare l’aggiornamento sia di dati primari che secondari. Sul tema della trasparenza e
condivisione dei dati, nel settore chimico l’organizzazione Green Chemistry for Sustainability
sta creando una banca dati che contenga informazioni idealmente a disposizione di tutti i
player del settore.
Marco Pelucchi Presidente AIPEF (Associazione Italiana Poliuretano Espanso Flessibile)
ha sottolineato come il poliuretano paghi lo scotto della chemofobia, anche per una
mancanza di informazione sulla natura della produzione: un processo che non comporta
scarichi chimici nell’ambiente e che sta da anni vivendo una fase di ricerca di soluzioni che
lo rendano più ecocompatibile.
Negli ultimi vent’anni si sono sviluppate soluzioni per la grande quantità di sfridi e
sottoprodotti generati nella produzione e taglio. Il riciclo meccanico per sfioccamento
permette la realizzazione di agglomerati con densità e portanze maggiori di quelle originali.
È molto efficace per gli scarti di lavorazione, ma inapplicabile a poliuretani post consumo,
inquinati sia dal punto di vista batteriologico che chimico in quanto spesso prodotti fuori
dall’Europa con materie prime bandite.
Il secondo metodo di riciclo del poliuretano è quello chimico, realizzato a monte della filiera
da parte dei fornitori di materie prime che, lavorando con una reazione inversa, riescono a
ricreare polioli dalla materia solida. Allo stato attuale questi polioli hanno delle limitazioni
prestazionali e di costo, a differenza della terza via di utilizzo dello scarto poliuretanico: la
termovalorizzazione.
In allineamento con principi di eco design, è da incoraggiare la progettazione di arredi
monomaterici: scocca in legno e altri elementi interni del mobile imbottito possono essere
sostituiti da poliuretano di portanza adeguata, garantendo una gestione del fine vita
totalmente circolare. Un secondo aspetto stimolato dalla ricerca di miglioramento delle
prestazioni ambientali è quello della significativa riduzione dell’ingombro nel trasporto di un
materiale voluminoso per definizione.
Martina Lamperti, Founder Krill Design ha inquadrato i problemi dei piccoli player di fronte
alla complessità di valutazione dell’impatto ambientale. Krill Design è una start-up innovativa
nata con l’obiettivo di risolvere due problemi: la grande quantità di scarti organici prodotti
ogni anno dalle aziende dell’industria F&B e la scarsità di materie prime. La soluzione
individuata è una nuova materia prima seconda generata dai sottoprodotti organici delle
aziende. Krill è un materiale brevettato, biodegradabile e compostabile, con il quale vengono
realizzati prodotti per le stesse aziende che hanno generato lo scarto.
Se il primo materiale era stato generato dalle arance, oggi esiste una materioteca di
materiali diversi, sviluppati e testati, con caratteristiche tecniche comparabili alla plastica
tradizionale ma dotate di look and feel molto più naturali. La prova scientifica del rapporto di
Krill rispetto ai materiali di origine petrolchimica presenti sul mercato è arrivata però solo
grazie all’aiuto del Politecnico. Attraverso il lavoro di un dottorando, l’analisi di impatto dalla
culla alla cancello (cradle to gate), che dunque non tiene conto della fase d’uso, ne ha
permesso di misurare le emissioni di CO2 equivalenti. Sempre più clienti chiedono
certificazioni e LCA ma per un materiale nuovo come Krill è molto difficile reperire dati utili
per una misurazione puntuale e attendibile.
Andrea Mulloni, Head of Sustainability Arper, ha percorso la longeva missione di
sostenibilità dell’azienda. Già dal 2005, quando la parola sostenibilità era sulla bocca di
pochi, Arper operava con l’obiettivo di realizzare prodotti a basso impatto ambientale.
Quando l’LCA era per lo più appannaggio solo di food e packaging, Arper la utilizzava,
sebbene per lo più con un approccio compliance, cioè di verifica performativa di prodotti
progettati e realizzati indipendentemente da obiettivi misurabili attraverso l’LCA.
Certificare un prodotto che di fatto nasce da una risposta al mercato non lascia però molto
margine di azione. Questo approccio backward looking è stato capovolto circa tre anni fa,
quando si è deciso di partire con obiettivi di sostenibilità dalla fase di progettazione, che vale
per l’80% dell’impatto di un prodotto. Da qui la nascita di un ufficio Sostenibilità indipendente
dal Controllo Qualità e la genesi di prodotti come Catifa Carta.
Si tratta di una sedia realizzata con un materiale composto da ventinove strati di carta craft
uniti da un bio binder originato dall’emicellulosa del lino, dunque 100% biogenico, ma con
prestazioni analoghe a quelle di un multistrato tradizionale. Oltre all’utilizzo di un materiale
con un impatto particolarmente basso, il progetto si è spinto nella ricerca di una soluzione
creativa del fine vita. Il destino di quasi tutti gli arredi è la reimmissione nell’atmosfera del
contenuto di CO2 per decenni trattenuto, ad esempio, nel legno di cui sono fatti. Con Catifa
Carta Arper e una serie di partner hanno sviluppato un modello circolare. Le sedie dismesse
sono raccolte e, attraverso un processo di pirolisi, trasformate in biochar, un materiale con
diversi impieghi in ambito edilizio, industriale e agricolo, anziché generare CO2.